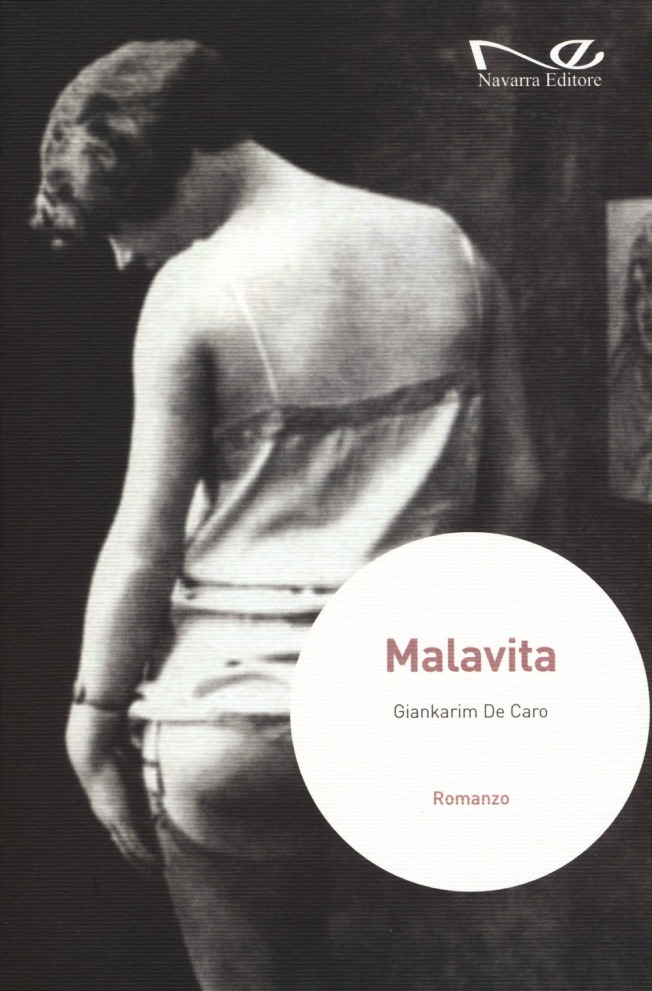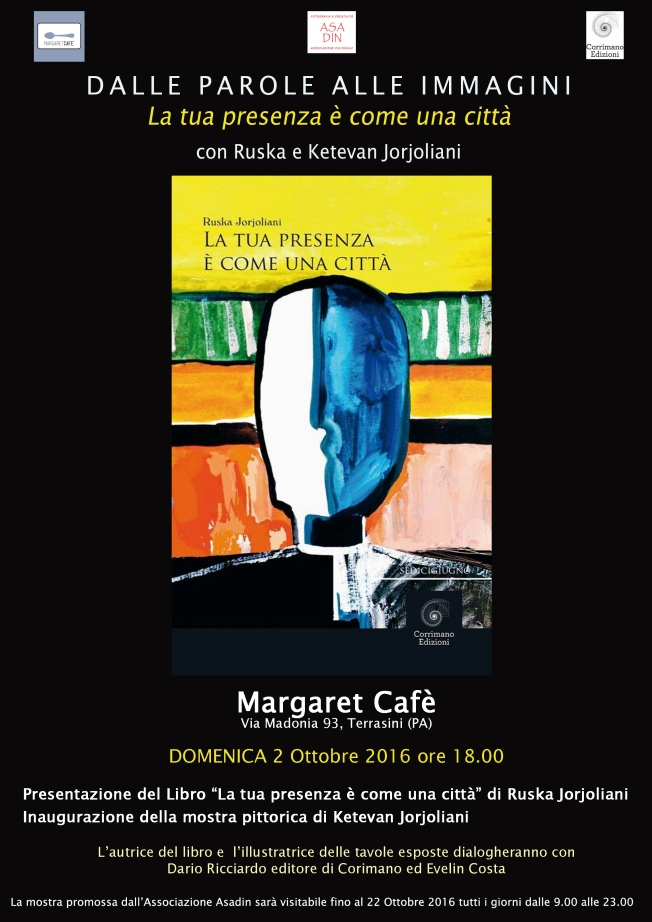Giorno 11 ottobre 2018 vediamo in gruppo il film “Sulla mia pelle”, di Alessio Cremonini, dedicato alla vicenda di Stefano Cucchi, trentunenne romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto una settimana dopo all’ospedale Pertini di Roma.
Coincidenza vuole che la data in cui decidiamo di vedere questo film rimarrà nella storia di questa dolorosa vicenda. Durante la giornata, infatti, arriva la notizia della grande ed inaspettata svolta avvenuta all’udienza del processo nel quale sono imputati cinque carabinieri per la morte di Stefano Cucchi. Uno dei carabinieri imputati, Francesco Tedesco, rompendo un muro di silenzio che aveva segnato il caso per tutti questi anni, ammette il pestaggio e accusa i colleghi Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo della violenta aggressione nei confronti del giovane. In questo momento il pensiero non può non tornare a Stefano e a quello che ha subito, ma anche alla sua famiglia ed in particolare ad Ilaria Cucchi, la sorella, che senza tregua da quasi dieci anni si batte per la verità e giustizia.
Una coincidenza che ha reso ancora più toccante la visione di un film che per tutto il tempo si focalizza sulla sofferenza e la tragica odissea di un ragazzo stritolato da un sistema solo all’apparenza democratico, ma nella sua concretezza vendicativo, crudele, violento, indifferente, lento, magmatico e monolitico nei mille gangli di una burocrazia che più che tutelare sembra voler imbrigliare e punire.
Stefano Cucchi non è un martire perché non è un Santo, ma subisce un martirio, non è un eroe, non è l’eroe di nessuno, anzi è un antieroe, rappresenta la parte più fragile e oscura della società, è vittima di se stesso e di una serie di ingranaggi sistemici che schiacciano senza pietà e senza sconti chi è debole e incapace di sorreggersi, chi fa scelte sbagliate, chi non riesce a salvarsi. La domanda che implicitamente percorre tutto il film è se chi è fallace, delinquente, debole, meriti per questo la tortura o la morte, se si può morire tragicamente e in solitudine all’interno delle mura di uno Stato, che ipocritamente afferma di voler riabilitare chi sbaglia e che invece si rende colpevole ed incapace di dare risposte alle proprie inadeguatezze.
“Sulla mia pelle” è un film che non specula sulla violenza e sul dolore, non celebra e non assolve nessuno, non colpevolizza e non crea santini. Tutti i protagonisti del film sembrano anelli deboli di un sistema sbagliato, nessuno ne esce positivamente, nessuno è vincitore. E’ una storia di perdenti, di persone vere, umane anche nella miseria umana e addirittura nella disumanità. E’ la storia di un ragazzo che non riesce a sopravvivere a questa società, si rifugia nella droga, delinque e dopo tanti tentativi di riabilitarsi continua a non farcela, è la storia di uno di tanti, di quelli che soccombono, perché non sempre nella vita c’è il lieto fine, anzi forse non c’è quasi mai. E’ la storia di una famiglia per bene, una famiglia stanca ed impotente che non sa più sostenere questo figlio caduto in un tunnel, che ogni volta che si rialza nel suo metaforico ring crolla subito dopo con tutto il suo peso. Dopo anni di tentativi e speranze disilluse, al momento dell’arresto prevale lo sconforto, la delusione, l’amarezza, la sofferenza, l’inadeguatezza. Il film mostra l’arrendevolezza di questi genitori di fronte agli ostacoli di una burocrazia che non è a misura umana; la madre, come tante mamme nella stessa condizione, si domanda se una notte in carcere potrebbe forse dare una lezione al figlio. Ha fiducia in uno Stato che poi si rivolterà contro di loro.
Il voler rispettare le regole può frenare la capacità di analizzarle per capirne l’essenza che non sempre è positiva. Non ci insegnano a pensare, a ribellarci, a disobbedire alle regole disumane, a favore di una legge universale che tutela l’essere umano, siamo abituati ad accettare ciò che è imposto senza ragionare e ad abbassare la testa.
La fiducia nello Stato porterà questa famiglia a seguire le regole di un sistema che complica la vita, che sembra spingerli ad adattarsi, a combattere poco, ma come non capirli? Chi ne è capace e chi può farlo? Lo Stato è democratico, ma complicato e può fare paura.
E poi nel film c’è lo Stato, lo Stato è rappresentato da diverse persone. I Carabinieri violenti e crudeli, quelli che probabilmente hanno devastato il corpo e la mente di Stefano, quelli che, secondo la testimonianza del loro collega, lo hanno massacrato con una violenza inaudita. Braccia armate di uno Stato punitivo? Vittime essi stessi dell’ essere “carne da macello” buttata nel peggio della società per miseri stipendi e con la tentazione di abbrutirsi? Bulli crudeli che agiscono indipendentemente dal sistema o frutti di un sistema sbagliato nelle sue viscere? Non c’è risposta. Non c’è giustificazione. Si vede solo che la violenza è ingiusta, qualunque sia la colpa commessa.
Ci sono poi le guardie carcerarie, quelle che ogni giorno condividono la reclusione. Il carcere è brutto in sé, il carcere non salva nessuno ed è punitivo anche per chi ci lavora. Ci sono gli altri carabinieri quelli che cercano di aiutare il ragazzo, ma si stancano subito di farlo, perché non c’è tempo per lui, non c’è tempo per gli ultimi. C’è una Giudice frettolosa, l’avvocato demotivato, ci sono gli infermieri ed i medici, tutti sembrano capire poco la gravità della situazione, probabilmente perché l’abitudine li ha anestetizzati ed immunizzati al dolore, forse disumani, ma anche umani nella loro indifferenza.
E poi c’è Stefano che non si fa aiutare, non permette a nessuno di salvarlo, in una sterile e flebile protesta contro quello che gli sta accadendo, nella totale inconsapevolezza di essere a rischio della propria vita, paradossalmente pensa al futuro, teme ripercussioni da parte dei carabinieri che pensa di incontrare di nuovo per le strade delinquenziali della sua città, pensa che a casa ha altra droga e teme di essere scoperto e di avere altre conseguenze, ragiona con la mente obnubilata dalla droga, dal dolore e da una strana lotta per la sopravvivenza che lo porterà invece ad abbandonarsi alla morte. Stefano ha sbagliato, Stefano non si fa aiutare, Stefano non sa salvarsi, Stefano ha voglia di mandare a quel paese tutti, dottori, polizia, guardie, parenti, non si rende simpatico agli altri e non sa usare né il pietismo, né l’empatia per avvicinare chi entra in contatto con lui, non si fida di nessuno, caccia via tutti, ma merita di morire per questo?
E’ una storia di difficoltà, dolore, indifferenza, solitudine. Stefano è solo e mentre guardiamo il film tutti ci sentiamo soli, chiusi in gabbia, abbandonati da tutto.
Se la domanda è: “è possibile entrare vivi in un carcere che è un luogo dello Stato ed uscirne morti dopo una settimana”, a questa domanda si può rispondere con altre domande: “Il carcere è un luogo dove è tutelata la vita? Esiste la tortura di Stato? Il carcere può essere umano? Lo Stato come considera chi è ultimo tra gli ultimi?”.
Ilaria Cucchi, La sorella di Stefano, ha intrapreso una battaglia legale in difesa di suo fratello “morto per Stato”, in cerca della verità, è una lotta importante nel nome di tantissime persone che come Stefano muoiono nelle carceri ogni giorno, da suicida o da suicidati, di tanti che vengono picchiati dentro le caserme in quel sottile limite tra regole e non regole.
Ilaria Cucchi per questo è stata criticata, accusata, sviscerata in ogni aspetto della sua vita, “bullizzata” anche dalla politica, ma è stata sostenuta da quelli che non hanno la forza o le possibilità di lottare in casi simili e da lei si sono sentiti rappresentati e da chi si impegna nella difesa dei diritti umani.
Il caso ha visto depistaggi e omertà, ma senza sosta questa donna ha continuato la sua battaglia legale e con le istituzioni, anche se queste non sono state sempre buone con lei, con la sua famiglia e ancor prima con suo fratello. Adesso, in seguito alla confessione di uno degli imputati, saranno molti a doversi scusare.
Mentre il processo dovrà seguire il suo corso, bisognerebbe portare avanti una battaglia collettiva sulla disumanità che si vive nelle carceri, che più che riabilitare ricreano o acuiscono le condizioni per delinquere anche dopo aver scontato la pena.
Sentiamo con troppa facilità inneggiare alle carceri, quando le carceri sono per essa stessa natura un non luogo dove si interrompe l’umanità. Dovremmo invece riflettere su altre alternative alla reclusione, perchè una società civile e a misura umana dovrebbe essere dalla parte degli ultimi, sostenere e non solo punire chi cade.
Difficile restare indifferenti a “Sulla mia pelle”, lascia attoniti, scossi e doloranti. Magistrale l’interpretazione di Alessandro Borghi, credibile ed autentico in ogni sequenza di un film sincero e capace di suscitare più dubbi che risposte.
Ci si augura che venga fatta verità e giustizia e che in una società civile e umana non ci siano più le condizioni che possano far accadere un episodio come questo.
Evelin Costa